|

Resti dell'antica mole veneto-bizantina, con
traccia dei ritocchi gotici sul fianco verso la
Salizzada

Il pozzo nel giardino
con l'emblema dei Cappello

Il pozzo nel giardino
con l'artiglio dei Malipiero
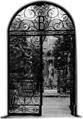
L'ingresso dal "portego"
del piano terra al giardino
|

Il portale veneto-bizantino
con l'arma dei Malipiero
Lo sviluppo architettonico della Cà Grande
di San Samuele
La Cà Grande di San Samuele è
dotata, come tutti i palazzi veneziani,
di due piani principali sovrapposti, ma in questo caso
ognuno è servito da una propria scala, Porta d'acqua
e Porta sulla calle, indipendenti. Al secondo piano nobile si
accede attraverso il più antico portale bizantino,
mentre, dalla porta principale si accede al grande atrio
seicentesco, che conduce al maestoso appartamento del primo
piano nobile a cui sono annessi un grande cortile monumentale, la
porta sul canale e il contiguo giardino settecentesco.
L'architettura del Palazzo rispetta nel suo sviluppo la tradizione
di molti palazzi veneziani, con quella libertà e armonia
progressiva di strutture che hanno creato i ritmi pittoreschi e il
fascino estroso della città.
L'edificio rivela infatti i segni stilistici della sua
multipla nobiltà architettonica, indici di tre epoche
sovrapposte l'una all'altra: la bizantina, la gotica e la
sei-settecentesca.
Il Palazzo venne edificato, assieme
ad alcuni edifici retrostanti, dai Soranzo tra il
X e XI secolo in stile veneto-bizantino, come proverebbero
il grande portale (al 3201) e la quadrifora con archi a schiena
d'asino (oggi inglobata nella successiva fabbrica gotica),
situati nel prospetto rivolto verso la chiesa di S. Samuele.
Verso la metà del '300 i Soranzo aggiunsero all'antica loro Ca'
Grande un secondo piano, come rivelano le forme archiacute delle
finestre. La nuova parte gotica si adattò così al
sottostante piano a loggia, rispettando e incorporando elementi della
costruzione bizantina.
Dopo la metà del '500 poi, i Cappello
decisero di operare un ampliamento del Palazzo, prima di allora avente
un impianto visibilmente più stretto e corto, sfruttando uno
spazio vuoto sul lato del giardino che portò la facciata
sul Canal Grande ad assumere l'attuale larghezza.
L'ampliamento del Palazzo continuò con Catterino Malipiero che
nel 1622 portò a termine la costruzione di un nuovo ampio
androne d'accesso (il 3200) all'appartamento del primo piano nel luogo
dove prima vi era un piccolo palazzetto appoggiato posteriormente a
quello sul Canal Grande; edificio di cui gli archi riprodotti qui a
fianco sono la testimonianza più evidente.
Nella seconda metà del'600 il Palazzo, con il suo
aspetto architettonico che ignora il barocco, è tra i
più ricchi e significativi di Venezia.
Prima della metà del '700, infine, i Malipiero portarono a
termine, seguendo un articolato progetto ora perduto, un'ulteriore
vasta ristrutturazione con l'intento di dare al loro Palazzo una
ancora più ampia e degna forma. Il Palazzo fu quindi unito,
eliminando la calle che li divideva, all'edificio posto sul lato
posteriore unificandone l'aspetto sulla facciata verso il campo.
Oltre a ciò ampliarono il giardino, inglobando anche parte
del Ramo Malipiero che costeggiava il Palazzo, e crearono così
un nuovo asse prospettico che dall'entrata principale sul campo
portava al giardino attraverso il cortile. Ciò è testimoniato
chiaramente dalla riproduzione del Palazzo realizzata dal Carlevarjs
attorno al 1718 riprodotta nella
home page di questo sito. Vi si nota chiaramente come il
lato del Palazzo verso la chiesa risulti terminare subito dopo le due
porte d'accesso e non, come oggi, una trentina di metri dopo.
Dalla stampa si nota inoltre come dopo queste porte l'edificio
fosse delimitato da una calle, detta Malipiero, oggi scomparsa (anche
se nel '900 il toponimo fu recuperato cambiando nome alla vicina
Calle della Commedia ove era nato Giacomo Casanova).
Nell'800 il Palazzo venne forse trascurato ma si conservò
intatto nel suo impianto settecentesco ed è solo con l'inizio
del '900 che cominciarono alcuni lavori di recupero, fino a
quando la famiglia Barnabò, attraverso radicale il restauro
eseguito negli anni '50 sotto la supervisione di Nino Barbantini,
non restituì definitivamente al Palazzo, al suo interno ed
al suo unico giardino l'antico aspetto.
E sarÓ quindi solo con l'inizio del 21 secolo, con l'arrivo dei nuovi proprietari, che Palazzo Malipiero potrÓ aspirare a ricevere attenzioni degne di persone in grado di rispettarlo e perdersi cura.
|